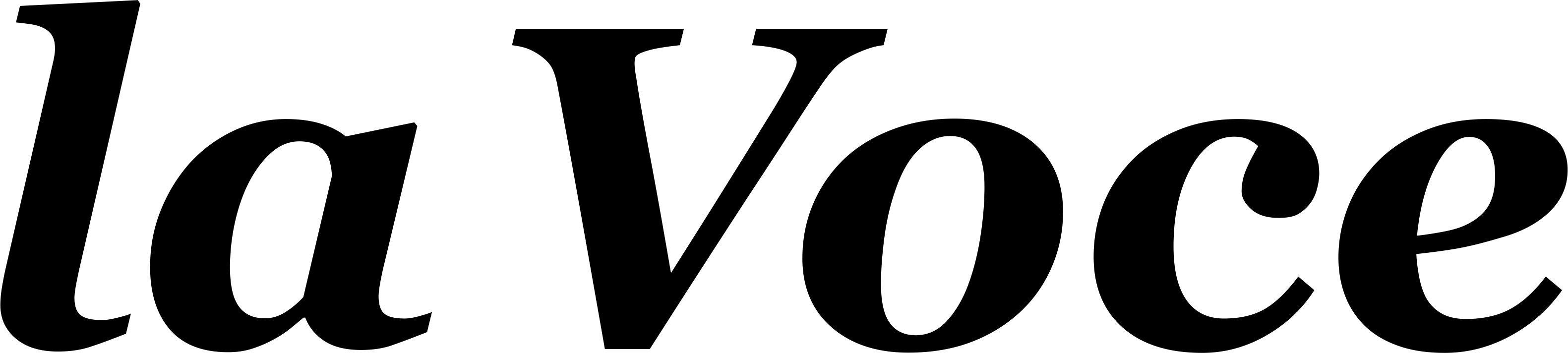Carta Vetrata/ Caffè amaro (da “Incompiute” raccolta di racconti)
di Stefania Origlia
“Così non va, te lo dico.” Mi stava addosso da settimane e quasi a fine turno si presentò, mani sui fianchi. La mia compagna di turno si girò a guardarmi per osservare la mia reazione.
“Ho dei problemi con la mia auto che è fuori uso almeno per le prossime due settimane. Ne avevo già parlato con la direzione. Purtroppo la prima corsa del treno è alle 6:40. I ritardi mi verranno scalati dallo stipendio, perché non mi sarà possibile in alcun modo recuperarli. Non so davvero cosa altro fare.”
La caposquadra mi guardò con quella sua faccia gommata, ricoperta di abbronzatura posticcia di quelle che ti vendono a pacchetti da dieci, in abbonamento, nei centri estetici, solo se sei una cliente fidata. Aveva messo su un mezzo sorriso che presto si trasformò in una smorfia di disgusto, le labbra storte e un reticolo di rughe sul mento. I capelli sottili e crespi, addomesticati dalla piastra, costretti da un elastico, la faceva sembrare una specie di scopettone fatto con le fascine di rametti secchi, di quelli che usano i netturbini per le strade . “Te lo dico per l’ultima volta, se arrivi tardi mi scombini il turno tuo e il lavoro di tutte le altre. Organizzati come ti pare, altrimenti passi alle notti”. E mentre lo diceva si allontanò a grandi passi, stringendo la cartellina con il foglio firme, tra le mani. Sfoggiava delle unghie lunghe e affilate di un vomitevole color verde bottiglia, certamente consigliato da qualche manicure di periferia. “E’ proprio una stronza!” mormorò la mia collega di fianco. Un’altra le rispose immediatamente “Fa quello che le dicono di fare, è solo un cane da guardia”, cercando goffamente di difenderla in qualche modo, dato che ci andava a pranzo insieme da un po’e aveva iniziato da ancor prima, un’opera di oliatura nei suoi confronti, per avere la possibilità di qualche cambio turno dell’ultima ora, senza dover affrontare discussioni con le altre. Una alle mie spalle se ne uscì con “Ma perché non provi a chiedere le notti solo per un mese?” e neanche feci in tempo a girarmi che subito un’altra a due postazioni più in là, rispose al posto mio. “Ma stai scherzando? C’è gente qui che sono mesi che ha fatto richiesta, poi vi lamentate se qualcuno chiama il sindacato!” Chi lo chiama? Tu, stronza. La mia vicina toccandomi il braccio con il suo gomito mi disse sottovoce “Ma perché non ti fai dare i passaggi da quello del centro di smistamento? Ha i tuoi stessi orari!” Per farmi toccare il culo ogni volta in segno di riconoscenza? Non lo dissi ma la guardai soltanto e lei sembrò avesse capito perfettamente e con una alzata di spalle mi guardò, a sua volta, come a dire “che vuoi farci?” Niente. Non voglio farci proprio niente. Andai dalla caposquadra. “Non volevo assolutamente creare problemi ma non so proprio come fare” le dissi, cercando di sembrare mansueta. Era con gli occhi incollata allo schermo del pc e non li alzò neanche di un millimetro, stava ordinando un rifornimento di cancelleria per l’ufficio, sgranocchiando gallette di riso che parevano di polistirolo ingiallito. “Non so che dirti, parla con la direttrice.” disse in tono monocorde. Che frustrazione, che stanchezza prestarsi a tutto ciò, senza poter gridare. Assecondare i ridicoli giochi di potere di gente da due soldi che, appena seduti ad una scrivania, dopo una vita con ai piedi le scarpe antinfortunistica, ti sbattono in faccia la loro ignoranza arrogante, dimenticandosi immediatamente della topaia in cui avevano stazionato per giorni e notti, sbuffando e bestemmiando. Io mi ero laureata in Diritto Amministrativo con il massimo dei voti e non sono mai stata la persona giusta nel posto giusto. Non ero stata fortunata. I miei posti erano stati tutti sbagliati, tutti inadatti, tutti mal sopportati. Ero sempre fuori tempo, rispetto alla partitura che mi era stata assegnata. Ma lavoravo come un mulo, fino allo sfinimento. Non potevo permettermi, la sera a casa, di restare sveglia troppo a lungo a pensare. E poi era un modo per astrarmi da quel contesto, quindi lavoravo duramente, senza parlare troppo, anche perché c’era ben poco di cui parlare. Una volta mi portai dietro un paio di libri che tirai fuori solo durante la pausa per buttarci un occhio, tra le briciole di un panino addentato di fretta e un caffè amaro, preso al distributore. Lo vedevo che mi guardavano ridendo e prendendomi per il culo. Dopo un paio di giorni, sempre durante la pausa, vidi arrivare un altro caposquadra che bonariamente mi consigliava di non portare “quella roba” in ufficio. “Altrimenti poi dicono che ti metti a leggere e non lavori e poi…” concluse “…lo sai come sono queste.” Con alcune si poteva parlare solo di serie TV, di film demenziali o programmi trash pomeridiani. Con altre, si era ammesse alla chiacchierata condivisa solo se si parlava male di qualcuno o se si era in grado di riportare, in modo dettagliato, qualche gossip che a loro era sfuggito. Altre parlavano solo di tragedie e malattie, operazioni andate male, madri morenti con Alzheimer, fratelli disoccupati. Con alcune di loro si riusciva a prendere un caffè e a fumarsi una sigaretta ma sempre dannatamente di corsa come se fossimo delle rifugiate in fuga da chissà quale orribile sciagura. E con gli uomini non andava meglio, ma almeno si parlava di viaggi e di sport e qualche volta di pesca d’altura ma solo fino a quando un culo tondo di una avventrice non prevista, veniva intercettato mentre entrava lì nello spazio bar che ci era stato concesso dall’azienda. Tutti gli sguardi dei presenti, colleghe comprese, si catalizzavano su quello e i magazzinieri a quel punto iniziavano a raccontarsi tra loro sottovoce di quelle che erano riusciti a scoparsi la sera precedente. Il più delle volte erano tutte balle, ma tutti facevano finta di crederci, tutti a darsi la pacca sulla spalla tra loro, tutti a immaginare scenari pruriginosi per eccitarsi un po’.
La stanza della direttrice era l’unica veramente luminosa di tutto il piano. Una reggia, rispetto allo sgabuzzino addobbato come un camerino teatrale, della caposquadra. Quando mi vide sulla porta mi sorrise e mi fece cenno di entrare. Aveva il volto simpatico e placido di chi era all’oscuro di un mucchio di cose, lì dentro. Mi aveva in simpatia, così istintivamente, e mi chiese se volessi un caffè, principalmente per mostrarmi la sua nuova macchina Nespresso rossa fiammante, alloggiata sul tavolino alle sue spalle. Le spiegai con la massima chiarezza cosa fosse accaduto ma la risposta fu esattamente quello che mi aspettavo. “Tesoro, siete in tante, se la caposquadra ti ha detto così evidentemente non può fare altrimenti.” Già. Evidentemente. Quindi ero da punto a capo. La macchina fuori uso, bus inesistenti, l’unico treno aveva orari inconciliabili con i miei turni di mattina, cambi turno non dovevo neanche azzardarmi a chiederne. Se non avessi voluto soccombere allo sconvolgimento della mia routine con mia figlia, portarla la sera a dormire per sempre da mia madre o da qualche volenterosa amica di turno per portare due soldi in più a fine mese, ma non riuscendo quasi più a vederla e spendendoli in caso di emergenza per pagare qualche baby sitter svogliata o peggio sdebitarmi con qualcuno dell’accollo della mia bambina-pacco, avrei dovuto farmi toccare il culo dal mio collega per un mese o poco più, ogni mattina mentre scendevo dalla sua auto, offrendogli magari anche il caffè, prima di passare il badge all’ingresso.
La gente è convinta che la vera meschinità si annidi soltanto ai piani alti dove loschi figuri si approfittano delle situazioni disagiate della povera gente. La verità è che le infamie più odiose, le coltellate alle spalle, i ricatti morali più bassi, li avevo ricevuti proprio da certi poveri mentecatti, gente che prendeva il treno con me e poi la metro, che sfruttavano i due soldi di pensione di qualche famigliare ignaro, per qualche spesuccia fuori budget. Erano gli stessi che facevano sciopero per presenziare alle riunioni sindacali mettendosi in fondo all’aula e restare tutto il tempo a parlare sottovoce al cellulare. Gli stessi che sfruttavano l’invalidità di qualche parente per grattare un paio di giorni liberi e pagati in più, al mese. Gente piccola che si aggirava in mezzo a gente normale che faceva fatica a tirare fino a fine mese e a metà già boccheggiava. La società li aveva trasformati in residuati bellici e molti di loro si erano arresi davanti l’evidenza per cui l’unico scopo era riuscire in qualche modo ad avvelenare anche la vita degli altri, parlare della merda altrui, perché a spalare sempre la propria si viene sopraffatti dal tanfo, che diventa insopportabile. Noi manovalanza eravamo buoni per il cottimo mentre gli scarti umani, quelli che non voleva nessuno, venivano confinati nei posti più infimi, da quelle aziende che così si mettevano la coscienza a posto, lustrandosi del fatto che avevano fatto attenzione alle esigenze di ogni singolo lavoratore, soprattutto se disagiato. Chi era in grado di capire tutto ciò, iniziava dunque a sputare addosso a qualunque cosa, lamentandosi del fatto che non eravamo niente, non saremmo mai stati niente, destinati ad appassire annichiliti qui, fino alla fine, come quelli che ci avevano preceduto. E i giovani finalmente approdati alla loro prima esperienza lavorativa, che arrivavano il primo giorno timidi e ossequiosi, venivano subito appesantiti da questa zavorra nera e velenosa, perché tanto sarà così anche per voi, non vi illudete, non cambierà, non cambia mai nulla per quelli come noi. Ho provato a resistere i primi tempi, a contrastare, ma nessuno è disposto a seguirti, nessuno ha voglia di provare ad essere diverso. Se lo fai diventi uno zimbello, una puttana, una matta. Il modo per spegnerti loro lo conoscono, perché sono animati da niente altro che rabbia. Il loro unico scopo è quello di essere certi che tu resterai disperata quanto loro. Intrappolata nel loro stesso unto ingranaggio. Non hanno altri scopi. Solo tenerti ferma lì dove possono controllarti. Andai al secondo piano e chiesi dell’unico collega che poteva darmi un passaggio. Mi dissero che era sotto infortunio perché gli era caduto un cacciavite sulle dita del piede, durante un turno di straordinario. Rimasi un attimo perplessa ma dentro sentii una certa soddisfazione anche se la possibilità di evitare le notti era ormai ridotta a lumicino. Un ragazzo che aveva sentito la mia richiesta si avvicinò. Un ciuffo scuro a coprirgli quasi un occhio, braccia lunghe ma muscolose. “Ciao, senti, se ti serve un passaggio io abito praticamente a due traverse di distanza dalla casa del collega. Venivamo insieme nell’ultimo mese, perché io sono nuovo. Adesso però lui è in malattia e la macchina la devo prendere per forza. Se ti può essere utile non fare complimenti.” Gli sorrisi e gli spiegai che sarebbe stato almeno per un mese e che ovviamente gli avrei dato la mia parte di spesa per la benzina. Lui spalancò gli occhi come se fossi matta e la sua espressione mi fece sorridere. “Ma scherzi? Semmai mi offri la colazione il venerdì mattina, perché la sera faccio tardi, ho il turno di volontariato in ambulanza.” Lo guardai come un regalo bello, di quelli che pensavi di non poterti permettere. “Ci mancherebbe!” dissi sorridendo ancor di più. Le mattine fu sempre puntuale, mi stordiva di musica reggae già alle 6, ma aveva una risata bellissima, contagiosa. Avrà avuto una decina di anni meno di me e una ragazza che lo faceva disperare per quanto era distratta al volante. Aveva fatto già tre incidenti e lui l’aveva conosciuta proprio in ambulanza, in occasione del suo ultimo, il più grave. Gli raccontai di mia figlia, della laurea, del lavandino che gocciolava in cucina e del fatto che nessuno mi chiamasse mai per chiedermi come stavo. Mi guardò con pudore senza dire nulla ed io ricambiai lo sguardo con dolcezza e profonda riconoscenza. Spesso osservavamo gli altri nelle macchine accanto, buttando l’occhio fuori dal finestrino, durante il nostro tragitto, senza parlare, sereni. Capitava di guidare incontro all’alba, il cielo spennellato di luce, sembrava un dipinto. “Due cappuccini, una brioche e due mini ciambelle” dissi al barista, mentre il mio nuovo collega cercava lo zucchero di canna, scombinando la disposizione ordinata della zuccheriera sul bancone.
A guardarlo, una risata mi esplose improvvisamente senza aver avuto tempo di poterla trattenere. Lui mi guardò con quegli occhi spalancati sul mondo, puliti, ancora. Rise ancor più forte di me. Caddero tutte le bustine a terra, lui inciampò per cercare di evitarlo. Anche il barista iniziò a ridere. Non smettevo di lacrimare. Era ancora presto, potevo farlo. E intanto avevo ripreso a respirare.
Stefania Origlia