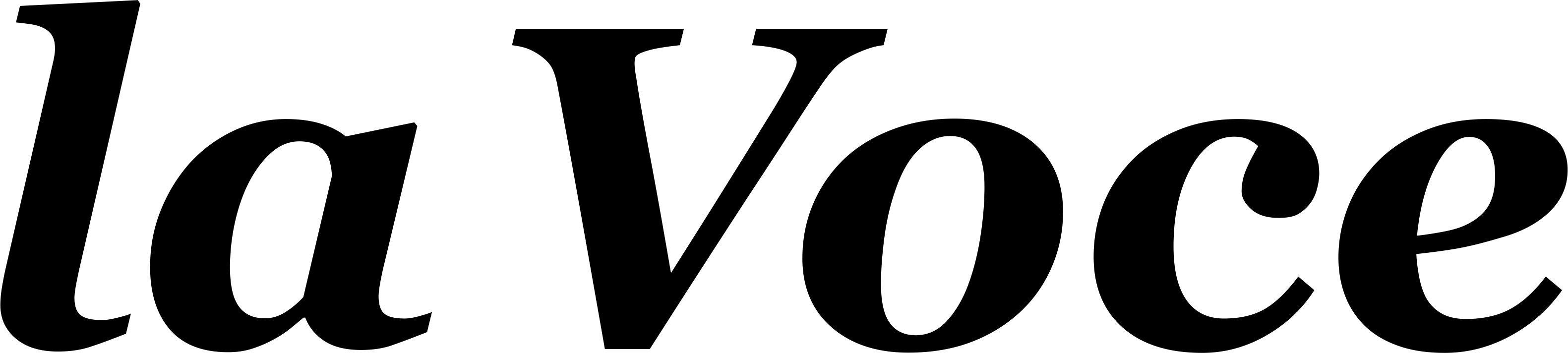di Stefania Origlia
Entrò in aula in quel modo spavaldo che hanno tutti quelli che sanno perfettamente l’impatto che suscitano, agli occhi degli altri. Era di una bellezza antica e fiera, i lineamenti definiti, il corpo tornito ma non violentato da sfiancanti sessioni sportive. La voce era ferma, lenta, interrotta solo da improvvise risate sonore, a volte disturbanti. Ero in quarta fila, spostata sulla destra e da lì potevo osservarlo attentamente. Quelle in prima, si agitavano sempre al suo ingresso per poi restare completamente ammutolite mentre lui procedeva alla sua magnifica svestizione giornaliera: la giacca lanciata sulla spalliera della sedia, il suo buffo e infantile “ciao ciao” con la mano per salutare la sua platea e poi, impugnato il pennarello, iniziava a scarabocchiare sulla lavagna, offrendoci lo spettacolo delle sue spalle ampie, dei suoi maglioni di pregio, dei suoi capelli mossi, lucidissimi, castani. Sembrava un giovane bellissimo, racchiuso nel corpo di un uomo forte e adulto. Una miscela letale, è giusto affermarlo, soprattutto per le mie colleghe della prima fila. Quel giorno si dilungò così tanto su un concetto che, colti dalla stanchenza, iniziammo a produrre un brusio di fondo sempre più evidente. Si fermò con il pennarello in mano e ci guardò, come quando ti fermi a guardare un semaforo aspettando che diventi verde, prima di iniziare ad attraversare. Fu in quella circostanza che mi accorsi che fermò il suo sguardo su di me, qualche secondo in più che sugli altri e la cosa mi mise in una situazione di così forte imbarazzo che con terrore constatai che le guance si stavano riscaldando e che sarei diventata una gigantesca mela rossa, da lì a poco. Ero ancora in preda alle mie elucubrazioni quando mi accorsi che il professore era di nuovo di spalle per continuare a torturarci e fu un sollievo enorme, tanto che scoppiai in una risatina isterica, tanto che il mio compagno di corso seduto a fianco, si girò e mi chiese cosa fosse successo.
Alla fine della lezione, il professore mi chiamò da parte. Di nuovo il sangue scaldò le guance. Il battito accelerato. Mi chiese, in tono pacato, di seguirlo. “Hai fatto un buon lavoro, ragazza. Leggermente al di sotto dei tuoi standard, comunque. Motivo?” E così dicendo allungò il mio manoscritto verso di me e si sedette alla sua scrivania, nell’aula di ricevimento. Aveva rimesso la giacca e anche gli occhiali che non portava mai in aula. Non mi guardò, perchè era impegnato nella correzione di una bozza. “Guardi, professore, non saprei cosa risponderle, sono sincera. Mi sembrava di aver fatto un buon lavoro.” A quel punto sollevò lo sguardo e mi guardò in un modo che mi è difficile descrivere anche ora. Ero la più grassa delle sue studentesse, la più bassa, la meno divertente. Portavo maglie ampie che, poggiando sul mio seno abbondante, cadevano giù dritte nascondendo così il mio addome prospicente. I capelli erano belli ma assolutamente senza definizione. Ero una di quelle che se ti passano accanto al supermercato, o per la strada o dal medico non ricorderai mai di aver incrociato. Tutte queste mie dolorose considerazioni furono bruciate da quel solo sguardo. Questa volta rimase su di me più di qualche secondo e mi sentii come irradiata. Devono provare esattamente questo le donne che vengono desiderate, pensai. Investite da raggi potenti che non lasciano scampo. Ero bella. Bellissima. Almeno così, diceva il suo sguardo. Uno sguardo di quel tipo non può mentire. Tornò con gli occhi sulla schermata del pc. “L’ho appena detto che si tratta di un buon lavoro, ragazza. Ti sto dicendo che devi solo alzare di più l’asticella. Se te lo chiedo è perchè puoi farlo. Ora mi devi scusare, ma ho da finire questa cosa. Ci vediamo mercoledì. Se incontri De Nero in corridoio, mandamelo qui.”
Durante il viaggio di ritorno, con la testa poggiata al finestrino del bus, tornai ripetutamente con la mente a tutto quello che era accaduto durante lo scambio di quelle tre frasi, tra lui e me. Già dire “tra lui e me” suonava ridicolo, imbarazzante. Io ero ridicola e imbarazzante. Sarei rimasta in piedi lì a guardarlo per un tempo indefinito. Non mi sarei stancata mai di lui. Arrivata a casa, lanciai borsa e manoscritto sul divano ed entrai in bagno e davanti lo specchio mi spogliai per disprezzarmi un po’, prima di entrare in doccia. Era un rituale quasi obbligato. Appena tolsi il reggiseno, i miei seni grandi e morbidi scesero verso il basso e sfiorarono l’addome. Ma gli uomini lo sanno quanto siamo brutte davanti allo specchio, quando siamo da sole, quando non dobbiamo dissimulare, inventare, camuffare, illudere? Ricordo che quando ero più giovane e frequentavo le palestre, c’erano delle ragazze fantastiche e così attraenti che era impossibile staccare loro gli occhi di dosso. Nell’intimità degli spogliatoi, però, erano brutte almeno quanto me. Le smagliature sui fianchi, i seni striminziti o di forme strane. Oppure enormi e cadenti, con aureole giganti e scure. Le spalle scese, i peli da togliere sul viso, le dita dei piedi storte, le fronti lucide, i nasi grandi ricorperti di fondotinta, piccoli brufoli sul mento, gli occhi insignificanti anneriti dal mascara. Erano magre, sì, ma quella magrezza sudata a fatica, imposta dal trend del momento, i culi svuotati da diete aggressive, le braccia muscolose per forza. Era in quella bruttezza condivisa nell’intimità di uno spogliatoio, che nasceva la nostra solidarietà. L’amicizia, no. L’amicizia era solo tra pari.
Davanti al mio specchio ero ora completamente nuda. Avevo un bel viso a detta di tutti. Anzi la frase che mi accompagnò per oltre quindici anni fu proprio “Hai un viso bellissimo, che peccato! Se solo ti mettessi a dieta!”
Per quindici anni, oltre al dramma di un corpo ingombrante, anche il senso di colpa di avere qualcosa di bellissimo e non saperlo in alcun modo valorizzare. Poi me ne andai. Iniziai a studiare fuori, un lavoro notturno in una videoteca così da potermi permettere un buco solo per me, senza doverlo condividere con altri studenti. Scelsi questo perchè in bagno, aveva sia la doccia che la vasca, e mi sembrò un lusso a cui non potevo rinunciare. I miei seni erano grandi ma belli, sì. Sono stati loro gli artefici del mio successo con i ragazzi, nonostante la mole non proprio da ballerina. Ne sono convinta. Continuando l’ispezione il mio sguardo scivolò sull’addome morbido e ondulato, e poi ancora giù sui fianchi ampi e le cosce polpose. Come ha potuto pensare questo di me, professore? Come si è permesso di dirmi quella bugia? Come è possibile che possa pensare, che tutto quello che ora vedo riflesso, sia meritevole di uno sguardo come il suo?
Aprii l’acqua della doccia e tra i fumi caldi e il bagnoschiuma al biancospino, provai ad immaginarlo fuori dall’università. La cosa più deprimente fu il fatto che quasi non osavo fare alcun tipo di fantasia su di lui, me ne vergognavo, non mi sentivo all’altezza neanche di quello. Mentre procedevo alla passata di balsamo sui capelli, mi ricordai che una volta lo vidi con una donna, di quelle alla sua portata per intenderci, di quelle che hanno sempre uno sguardo di sufficienza anche se sono di fronte al David di Donatello. Una così, insomma. Spero l’abbia severamente punita, almeno una volta, perchè quelle sono specie di donne che andrebbero mutate in piante grasse, per il bene dell’umanità. Certamente avrà mantenuto quello sguardo anche la prima volta che se lo trovò nudo nel suo appartamento in centro, una sera, dopo averlo invitato ad una cena di gran classe, di quelle che organizzano le donne come lei, quelle che non hanno troppi argomenti da snocciolare e decidono di snervare il malcapitato di turno con discorsi bislacchi sui vitigni del Müller-Thurgau, pur non capendo assolutamente nulla di vini e prima di concedersi nel dopocena senza farla sembrare una cosa volgare.
Il giorno seguente provai a lavorare sulla mia relazione, seguendo il consiglio del professore. Dovevo alzare l’asticella. Se non poteva considerarmi desiderabile, che almeno fosse orgoglioso di me. E quel pensiero mi fece provare all’improvviso un senso di tenerezza per me stessa, una cosa che non provai mai, fino a quel momento. Arrivò mercoledì e una volta arrivata all’università, presi velocemente posto in aula. Mi era mancato terribilmente. Assurdo ammetterlo anche a me stessa. Sbirciavo la porta a distanza, ben coperta dalle fila davanti, in attesa di vederlo entrare. Ero in preda alla stessa agitazione delle tre cretine della prima fila e questo mi mise in uno stato di profonda depressione. Non ero diversa da loro e la scoperta mi lasciò disgustata. Non volevo neanche immaginare quanti di quei sguardi aveva lanciato nel corso della sua carriera accademica, quante ragazze aveva turbato e quante colleghe si era portato a cena fuori. “Sono una povera idiota” pensai di me stessa e sorrisi di tanta ingenuità. Sorrisi della mia ingannevole percezione che insisteva a dirmi altro. Quando entrò, capii immediatamente che era contrariato e la cosa mi distolse completamente dai miei pensieri adolescenziali. Non volevo vederlo così. Non volevo in alcun modo che qualcosa potesse turbarlo. Consegnammo le relazioni in religioso silenzio alla fine della sua lezione e non riuscii a guardardarlo negli occhi. Alla fermata del bus, nel viaggio di ritorno, incontrai un ragazzo che seguì un corso di ceramica con me qualche anno prima e fu provvidenziale perchè iniziò a piovere a dirotto e lui aveva un ombrello enorme, neanche a farlo apposta. Restammo a chiacchierare così, sotto l’acqua, per un po’. Poi arrivò il bus e salii di corsa. Appena presi posto a sedere, lanciai il mio solito sguardo sul piazzale antistante l’ingresso della facoltà e lo vidi mentre parlava, braccia incrociate per ripararsi dal freddo, con un altro professore. Aveva appesa sulla spalla la tracolla porta pc, e annuiva mentre l’altro gli parlava fitto fitto all’orecchio. Entrambi sembravano fossero del tutto indifferenti al fatto che stesse piovendo. Poi, un momento dopo, si voltò verso il bus che era ancora fermo al capolinea e sembrò stesse cercando qualcuno come era successo in aula qualche giorno prima e di nuovo ebbi quella sensazione ridicola che quel qualcuno fossi io, perchè il suo sguardo una volta raggiunto il mio, si fermò.
Ci guardammo a lungo, stavolta, senza alcuna interruzione. Restammo seri, a guardare l’altro, come se fosse lunica cosa importante da fare. Lui, in piedi, fradicio, lì fuori, io spettinata seduta su un sedile di velluto. Il bus partì. Lui sciolse le braccia e mi salutò in fretta, in quel modo buffo che usava in aula, come un bambino lasciato dalla mamma davanti scuola e che continua a fare “ciao” con la manina, fino a che non entra. In quel momento capii che l’amavo ma non di quell’amore che si legge nei romanzi. No. Quel mio amore era un ronzio, una spina, una spilla, una morsa. Qualcosa che aveva il sapore aspro di un frutto non ancora maturato. Un amore scomodo, un amore celato. Un amore senza alcun senso.
La settimana dopo riportò le relazioni corrette e quando vidi sull’ultima pagina una riga netta a penna rossa, che tagliava come in due il foglio e sopra scritto “Alza l’asticella. Provaci!” fui assalita da un sentimento di rabbiosa frustrazione. Stavo per strappare il foglio quando decisi di andarci a parlare.
“Professore, mi scusi, avrei bisogno di parlarle.” Lui si voltò e il suo sguardo stavolta sembrò di sfida. “Io no, ragazza.” Restai di sasso ma non potevo farla finire lì. “E allora mi dica lei quando possiamo parlare con un po’ di calma.” Sembrava divertito dalla mia espressione. “In merito a cosa?” Lo guardai. “In merito alla relazione” dissi seria. Scoppiò a ridere. “Ma noi non abbiamo una relazione, ragazza!” Mi sentii improvvisamente inondata dalla vergogna ma lui stava ridendo e si stava prendendo gioco di me in modo così sfacciato che dopo un primo sussulto scoppiai a ridere anche io. Le ore che seguirono ci trovarono dentro una specie di bistrot di quelli amati dai giovani intellettuali, con un menù ricco di insalate improbabili e panini farciti con senape e maionese fatte in casa. Lui mangiò un paio di uova con della salsa a parte e si fece portare due toast con formaggio e funghi. Era affamatissimo e sembrava che quasi non mi ascoltasse mentre continuavo a blaterare con disappunto sul giudizio con il quale aveva cestinato il mio lavoro di giorni e giorni. “Ma non hai fame?” mi chiese guardandomi sfinito. Stavo morendo dalla fame ma ero in forte imbarazzo e non avrei mai mangiato davanti a lui. “No, professore, sono solo molto contrariata.” Tornò ad addentare il toast. “Non è colpa mia. Dipende da te. Quanti anni hai?” Aggrottai la fronte. “Cosa c’entra questo?” Mise giù il toast e si infilò gli occhiali per guardarmi meglio. “Ne ho 28. Saranno 29 fra un paio di mesi. Perchè?” Continuò a restare con lo sguardo dritto nel mio. “Sei la più vecchia del mio corso, quella più brillante, quella che non fa mai domande scontate. Quando ridi, a lezione, ti copri la bocca perchè non vuoi far vedere il tuo dente accavallato e sei molto elegante quando ti leghi i capelli in su e ti passi un filo di mascara. Ma sei lo stesso un’ idiota. Solo un’idiota, a 28 anni, non si rende conto di quando un uomo la sta osservando da lontano. Solo un’ idiota non ci proverebbe a capire di cosa si tratti.”
Ormai ero diventata un composto liquido che da lì a poco si sarebbe allargato sul pavimento del locale. Rimasi assolutamente immobile per timore di aver frainteso. Girai anche leggermente lo sguardo oltre il nostro tavolo per simulare indifferenza e padronanza della situazione, come se quella rivelazione fosse poco più che banale amministrazione per me. E’ in quel momento che lui si alzò, prese la sua tracolla, andò a pagare ed uscì lasciandomi lì come un pietra sulla sabbia.
Arrivai a casa solo un paio di ore dopo, ma non ricordo dove vagai fino al mio rientro. Ero sotto l’acqua della doccia, ormai senza pensieri tanto era la mia stanchezza, quando qualcuno si attaccò al campanello di casa.
Coperta da un accappatoio rosso e con i capelli ancora sgocciolanti guardai dallo spioncino.
Lentamente aprii come se non avessi più alcuna speranza di salvezza.