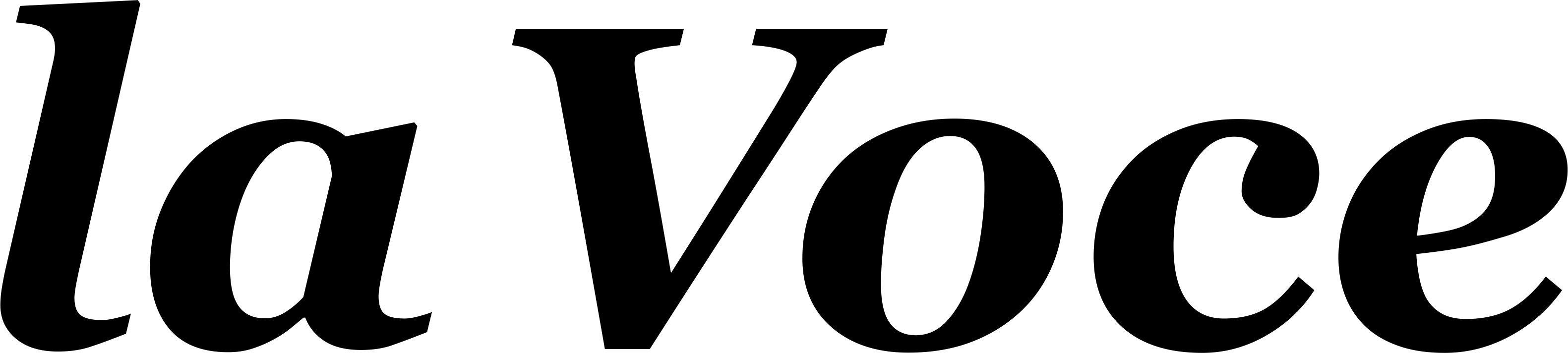Adagiato sulle verdi pendici di Monte Mario, in prossimità della Via Trionfale e della stazione ferroviaria di Sant’Onofrio sulla linea Roma-Viterbo, il complesso del Santa Maria della Pietà è molto più di un semplice insieme di edifici: una vera e propria “città nella città”, un luogo dove le vicende sociali, mediche e urbanistiche si sono intrecciate e trasformate per secoli. L’ex ospedale psichiatrico, intriso di storia, sta oggi vivendo una profonda rigenerazione, affermandosi come un dinamico fulcro di servizi, cultura, natura e arte. La storia del Santa Maria della Pietà inizia nel 1548, quando la Confraternita di Santa Maria della Pietà fondò un ospedale per i “poveri, forestieri e pazzi” di Roma. In quell’epoca, la malattia mentale era spesso incompresa e chi ne soffriva veniva emarginato. L’istituzione nacque come un primo tentativo, seppur severo, di dare un rifugio a queste persone, e già nel 1572 si concentrò specificamente sui “poveri pazzerelli”. Dopo un primo insediamento in Piazza Colonna, l’ospedale si spostò in Via della Lungara nel 1725 per volere di Papa Benedetto XIII. Fu però tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento che il complesso assunse la sua imponente forma attuale, divenendo l’ospedale psichiatrico più grande d’Europa. Con l’annessione al Regno d’Italia nel 1894, la gestione passò alla Provincia di Roma. Seguendo le nuove idee in psichiatria e la Legge Giolitti del 1904, si adottò il modello a padiglioni. Nel 1914, una nuova sede fu inaugurata a S. Onofrio in Campagna, a Monte Mario. Qui sorse un vero e proprio “villaggio manicomiale” con 37 padiglioni immersi in un immenso parco di centotrenta ettari. L’idea era offrire aria aperta e spazi verdi, considerati allora rivoluzionari per la “terapia” della mente. Ogni padiglione aveva una funzione specifica per i diversi tipi di pazienti, e il complesso era dotato di tutto: laboratori, lavanderie, cucine, una chiesa, un teatro, un sistema idrico e persino una fattoria con una colonia agricola e 23 edifici dedicati, inclusi una vaccheria e una porcilaia. L’edificio d’ingresso portava agli uffici direzionali, a una biblioteca, a una farmacia con laboratori r alloggi per suore, e una camera mortuaria. La struttura arrivò a ospitare fino a tremila pazienti dopo la Prima Guerra Mondiale diventando un punto di riferimento nazionale con l’Ufficio statistico per le malattie mentali dal 1938 e l’Istituto Neurologico Provinciale dal 1946. La Legge n. 36 del 14 febbraio 1904, meglio nota come Legge Giolitti, segnò il primo vero intervento a livello nazionale sui malati mentali, che venivano ufficialmente definiti “alienati”. Questa normativa stabiliva il ricovero obbligatorio nei manicomi: “Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo “, riflettendo una visione del malato più come un soggetto pericoloso da contenere che da curare. I ricoverati venivano privati degli effetti personali, identificati con un numero e costretti a indossare un’uniforme, subendo spesso trattamenti degradanti e “torture” per ogni comportamento considerato eversivo, arrivando ad annullarne l’identità personale. La storia dell’ex ospedale psichiatrico svela anche un’altra pagina amara rispetto alle donne internate non per malattia, ma per “devianza” sociale: fu infatti anche uno strumento per silenziare e disciplinare la libertà femminile, attraverso il controllo e la repressione. Durante la Prima Guerra Mondiale, molte finirono recluse per sintomi depressivi o traumi legati al conflitto. In epoca fascista, chi non rispettava l’ideale di “sposa e madre esemplare” veniva etichettata “malacarne” e internata, usando l’istituzione per imporre l’ideologia. Anche nel dopoguerra, un temperamento ribelle o “avventure amorose” potevano bastare per l’internamento. Questo dimostra come il luogo abbia, per troppo tempo, disciplinato e tolto voce a chi non si conformava. Con “L’altra verità. Diario di una diversa” la grande poetessa Alda Merini racconta, con una prosa lucida ma evocativa, i suoi anni di segregazione e sofferenza trascorsi in manicomio, segnati dalla privazione di ogni libertà, dalla pratica dell’elettroshock e dall’assoluto senso di distacco dal proprio corpo che non sentiva più suo. «Quando venni ricoverata per la prima volta in manicomio ero una sposa e una madre felice, anche se talvolta davo segni di stanchezza e mi si intorpidiva la mente. Provai a parlare di queste cose a mio marito, ma lui non fece cenno di comprenderle e così il mio esaurimento si aggravò, e morendo mia madre, alla quale io tenevo sommamente, le cose andarono di male in peggio tanto che un giorno, esasperata dall’immenso lavoro e dalla continua povertà e poi, chissà, in preda ai fumi del male, diedi in escandescenze e mio marito non trovò di meglio che chiamare un’ambulanza, non prevedendo certo che mi avrebbero portata in manicomio. Ma allora le leggi erano precise e stava di fatto che ancora nel 1965 la donna era soggetta all’uomo e che l’uomo poteva prendere delle decisioni per ciò che riguardava il suo avvenire. Fui quindi internata a mia insaputa, e io nemmeno sapevo dell’esistenza degli ospedali psichiatrici perché non li avevo mai veduti, ma quando mi ci trovai nel mezzo credo che impazzii sul momento stesso in quanto mi resi conto di essere entrata in un labirinto dal quale avrei fatto molta fatica ad uscire».