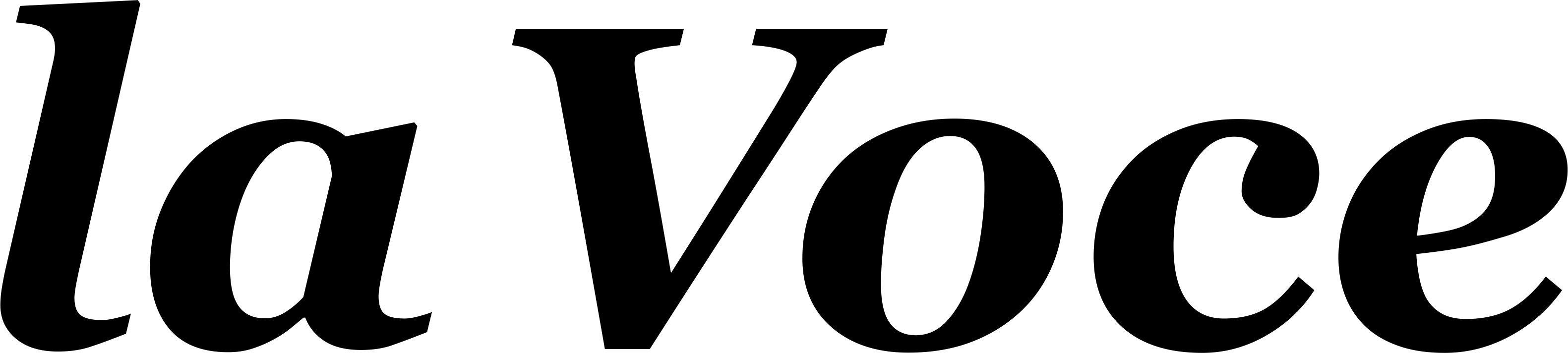È stato teatro di storiche battaglie e strategica via d’accesso alla città, rimasto in piedi nonostante le piene del Tevere e gli assedi militari, è poi diventato luogo simbolo della movida e delle promesse d’amore. Ponte Milvio è tra i più importanti ponti di Roma, nonché uno dei più antichi (la sua origine risalirebbe al III secolo a.C.). Intorno al 220 a.C., ai tempi della realizzazione della via Flaminia, fu ricostruito passando dal legno alla muratura e poi restaurato nel 109 a.C. dal censore Marco Emilio Scauro. Pur essendo “extra urbem”, ossia fuori delle mura della città, ha sempre ricoperto un ruolo cruciale per la sua posizione strategica tra le vie consolari Flaminia, Cassia e Clodia. Originariamente fu chiamato “Mulvius”, nome che probabilmente deriva dalla famiglia Mulvia che lo avrebbe commissionato, per poi essere denominato dal popolo, nel corso Medioevo, “Ponte Mollo”, pare a causa del crollo di un’arcata centrale e di una presunta instabilità del ponticello in legno successivamente installato. Altra ipotesi è che il termine derivi dall’espressione romana “andare a mollo”, in riferimento alle piene del Tevere che spesso sommergevano il ponte, il primo scoglio che il fiume incontrava entrando in città. Nel 312 d.C. fu teatro della celebre battaglia che, si narra, venne anticipata dalla storica conversione dell’imperatore Costantino che, accampato nei pressi del ponte, ebbe la visione di una croce con una scritta: “In hoc signo vinces” (sotto questo segno vincerai). Sconfiggendo Massenzio, Costantino I divenne imperatore unico d’Occidente. Nel Medioevo, il ponte subì ulteriori danneggiamenti a cui, nel 1429, Papa Martino V cercò di ovviare affidando i lavori di restauro all’architetto Francesco di Genazzano. Nel 1805, Papa Pio VII commissionò nuovi interventi affidandoli al famoso architetto Giuseppe Valadier che ne progettò il riassetto, inserendo le arcate esterne al posto dei ponti levatoi ed edificando una porta fortificata, la torre in stile neoclassico, conosciuta con il nome di Torretta Valadier. L’architetto eliminò ogni elemento ligneo e nel 1825 decise di collocare all’entrata nord le statue degli apostoli Pietro e Paolo, realizzate dallo scultore Francesco Mochi, che furono poi trasferite nel 1955 a Palazzo Braschi per un lavoro di restauro. Lì rimasero fino al 2016 quando venne deciso di riportarle nella collocazione per la quale erano state originariamente progettate: la Basilica di S. Giovanni dei Fiorentini (le statue che vediamo oggi sono copie realizzate e posizionate nel 2001). Nel 1849 Garibaldi fece distruggere una parte dell’arco e della pavimentazione del ponte per rallentare l’avanzata delle truppe francesi. Da allora, la struttura ha subito diversi rimaneggiamenti fino ad assumere la sua funzione attuale di passaggio pedonale (fino al 1985 era adibito anche al traffico delle auto!). Nel 2021, ACEA, ha dotato la Torretta Valadier di una nuova illuminazione artistica che, attraverso 16 proiettori a led a risparmio energetico, ne esalta le forme e l’architettura.